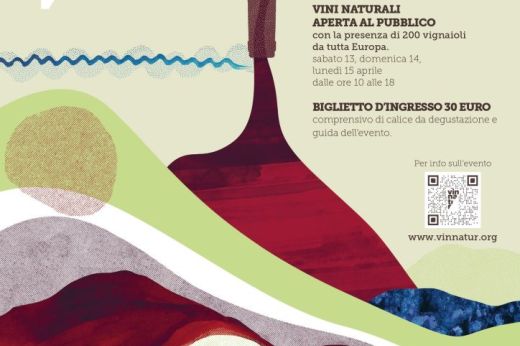Da sempre gli italiani che frequentano la montagna si schierano in due grandi categorie: gli estimatori della Valle d’Aosta e quelli delle valli dolomitiche. Sì, ci sono altri monti sparsi per l’Italia: Alpi Lombarde, Marittime, Friulane, Apuane, tutto l’Appennino, le catene delle isole più un’altra miriade; ma statisticamente i circondari di massima frequentazione sono di gran lunga quei due.
Gli schieramenti dei due partiti esprimono un campionario di opinioni che vanno dalla preferenza per una regione senza escludere però l’apprezzamento dell’altra fino all’integralismo da stadio di chi tende a denigrare ogni aspetto della parte “non gradita”.
In realtà mi sembra che le motivazioni degli uni e degli altri nel prediligere montagne comunque splendide si equivalgano e che la discussione lasci il tempo che trova: l’importante è comunque, dovunque, sempre, “andar per monti”. E non voglio ripetermi sull’etica di questa attività, avendo già espresso la mia opinione nel primo articolo di questa sezione.
Tornando ai termini della “competizione”, gli amici della Val d’Aosta affermano che nella Vallée è maggiore il senso della “grande montagna”, al quale concorrono i forti dislivelli, le quote elevate, la severità delle condizioni e la lunghezza delle escursioni. Verissimo. Ma è altrettanto vero che per la varietà delle forme, i colori della roccia, le prospettive sempre nuove, i giochi di luci e ombre, la magnificenza di albe e tramonti le Dolomiti non hanno uguali al mondo.
Sotto l’aspetto doloroso degli scempi edilizi vedo purtroppo una umiliante parità: le colate di cemento di Cervinia vanno sciaguratamente a braccetto con quelle di Madonna di Campiglio, giusto per citare i primi esempi che mi vengono in mente.
Nelle valli dolomitiche c’è un eccesso di rifugi, impianti di risalita e vie ferrate – accusano i fautori della Valle d’Aosta, e questo è innegabile: la realtà è sotto gli occhi di tutti e a poco vale far notare che nel novero delle località create dal nulla negli anni sessanta per assecondare l’esplosione della pratica sciistica di massa ne sono presenti anche di valdostane. Nessuno può scagliare la prima pietra.
L’equivoco di base sta insomma nell’impostare la questione in termini di raffronto. Rimane una guerra tra poveri senza vincitori e con un solo, grande perdente: la montagna nella sua dimensione più pura.
La mia competenza sul comprensorio valdostano si limita a sporadiche puntate sui sentieri della Valle di Cogne, Valsavaranche, Valle di Champorcher, Valtournanche e Val d’Ayas, esperienze troppo superficiali per esprimere opinioni attendibili. Ma delle valli del Trentino e Alto Adige ritengo di avere una conoscenza, sia “sul campo” che tramite una buona biblioteca tematica messa insieme nell’arco di oltre vent’anni, sufficiente per dare un giudizio (con licenza illimitata di confutazione da parte di chiunque).
Premesso che in questa mia trattazione mi riferisco sempre, non essendo sciatore, alla montagna estiva, credo che il discorso sui rifugi, gli impianti e le ferrate dell’arco dolomitico debba essere approfondito al di là delle pure cifre, che rivelano un’effettiva saturazione.
Lodevoli intenti da parte di Enti Locali e Associazioni sembrano però improntati negli ultimi tempi alla consapevolezza di essere arrivati al limite, dal che la tendenza, per gli impianti di risalita, allo stop di eventuali nuove realizzazioni destinando le risorse al mantenimento in perfetta efficienza di quelli esistenti. Almeno, fino a quando i buoni propositi non si arrendano alle pressioni delle multinazionali degli articoli sportivi e dei fanatici dei caroselli “da mattina a sera con gli sci ai piedi”. Non ho niente contro gli amici sciatori, del resto anch’io, se c’è una funivia che mi fa risparmiare mille metri di dislivello e tre ore di salita a piedi, la utilizzo: in presenza delle comodità è difficile essere “puri”. Ma alla smania di nuove piste in nome della famigerata e male intesa “valorizzazione” del territorio bisogna pur mettere un freno.
Un discorso analogo può essere fatto per le ferrate. Nate allo specifico scopo di facilitare l’accesso agli attacchi delle vie alpinistiche rispettando il principio di non portare gli infissi fino alle vette, diventarono gradualmente una forma di escursionismo più avanzato: si offriva cioè anche ai non alpinisti, a patto di un minimo di preparazione e di un’attrezzatura adeguata, di penetrare nel cuore della montagna e godere di scenari altrimenti preclusi ai comuni camminatori.
Fin qui tutto bene. Ma, sempre in nome della “valorizzazione”, giunse puntuale il momento in cui si cominciarono ad attrezzare le cime e a cablare traversate in cresta oggettivamente pericolose per terreno inaffidabile o esposizione ai fulmini. Si andò infine travisando il concetto di ferrata ideale, quella cioè che, ricalcando il più possibile una progressione naturale lungo stratificazioni, cenge, terrazzamenti, roccette, sporgenze, rientranze e gradinature, prevedeva la posa di infissi artificiali solo per garantire la sicurezza nei punti effettivamente rischiosi. Ebbe inizio la generazione delle ferrate sportive, realizzate conficcando pretestuosamente centinaia di metri di cavo d’acciaio su pareti verticali o superesposte per la gioia di percorritori in vena di atletismi, ignorando spesso percorsi più semplici e logici.
L’attuale tendenza in tema di ferrate pare sia analoga a quella già citata per gli impianti di risalita: nessuna nuova installazione, scrupoloso mantenimento e periodico rinnovo di quelle esistenti, smantellamento di quelle pericolose e abbandono (con relativa apposizione di cartelli di avviso) dei tracciati su terreni che ne rendano difficoltosa la manutenzione. Speriamo bene.
Ancora più delicato è il discorso sui rifugi. Anche se costituiscono una comodità, nelle Dolomiti sono ben più del necessario, diciamolo chiaramente. A tutti fa piacere avere punti di riferimento frequenti dove far sosta per riposare, ripararsi o trovare un minestrone e una tazza di tè senza doversi caricare lo zaino di viveri e bevande; esistono però itinerari lungo i quali ogni mezz’ora ci si imbatte in un rifugio, baita, malga o punto di ristoro che dir si voglia, con la conseguenza di riversare nel mondo alpino un esercito di gitanti, non tutti provvisti di quel valore che è la “cultura della montagna”.
E qui comincerò a rischiare l’impopolarità, dato che molti diranno: ma tutti hanno uguale diritto di godere degli spettacoli che la natura offre. Giusto. Ma le comitive chiassose, le scorribande di ragazzini invadenti davanti e dentro i rifugi, le radioline a tutto volume, il coro dei telefonini con il contorno delle lattine e delle cartacce sparse all’intorno ci dicono che forse del tutto giusto non è. E chi pensa che esagero o sono intollerante, si rechi un giorno d’estate lungo l’insensata strada a pedaggio che porta al Rifugio Auronzo; cito questo come esempio significativo ma il discorso vale per tutti i “rifugi” (le virgolette sono d’obbligo) raggiungibili in auto. Là si metta in coda al self-service insieme con i giulivi vacanzieri in canotta e ciabatte da spiaggia, si faccia prendere a gomitate in una seconda coda al banco dei souvenirs e provi poi a trovare un angolo non affollato all’esterno per ammirare lo scenario delle tre Cime di Lavaredo; ci riuscirà forse dopo il tramonto, quando le orde, non senza avere lasciato chili di testimonianze tangibili della civiltà dei consumi, saranno ormai sciamate verso gli alberghi del fondovalle. Allora, in quell’improvviso silenzio, potrà provare a chiudere gli occhi e con un po’ di fantasia riuscirà magari a immaginare quel posto com’era cent’anni fa: niente asfalto, niente automobili, niente Disneyland ma un vero, glorioso Rifugio dove guide e alpinisti si scambiavano racconti sulle ascensioni fatte e scrutavano il cielo cercando di capire se l’indomani ci sarebbe stato sole o pioggia.
Diranno ancora: ma gli incassi dell’Auronzo e degli altri rifugi a portata di automobile non costituiscono una ricchezza che il C.A.I. ridistribuisce garantendo il mantenimento dei sentieri, delle ferrate e dei rifugi meno frequentati (o per lo meno così dovrebbe essere)? Il discorso è senza dubbio spinoso (a Genova abbiamo un proverbio che, tradotto, dice “non si può soffiare e insieme succhiare”): nessuno, tantomeno io, ha la ricetta miracolosa né voglio disconoscere i meriti del C.A.I., storico divulgatore degli aspetti sani della montagna (e del quale sono socio). E allora? Come uscirne? Istituire il numero chiuso? Irrealizzabile e antidemocratico. Severe multe per chi sporca o fa chiasso? Sacrosanto, ma di difficile applicazione. Cartelli riportanti norme di comportamento? Inutili, chi ignora il rispetto per gli altri e per l’ambiente non lo impara certo da un cartello. E pensare che basterebbe una normale educazione familiare, un normale indottrinamento scolastico, un normale buon senso, una normale sensibilità.
A tutte le parti in causa, e che nessuna si senta esentata, il compito di trovare il punto di equilibrio per salvare le montagne più belle del mondo. Vogliamo provarci?